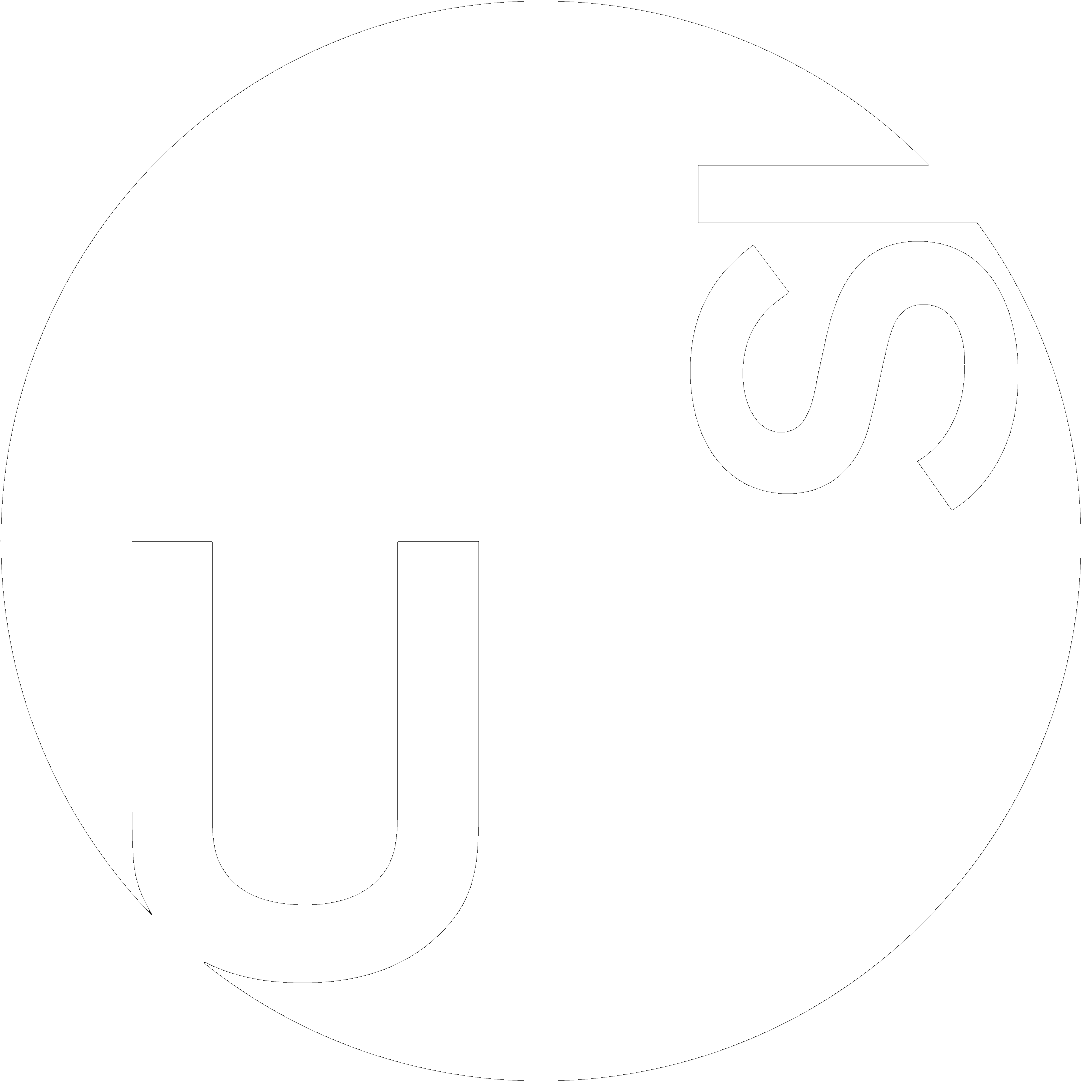|
Cosa può la letteratura, e come. Le forme del conflitto |
«Come pensare il conflitto altrimenti che nella prospettiva del suo superamento?» A partire da questa domanda, formulata da Miguel Benasayag e Angélique Del Rey nel loro Elogio del conflitto, si sviluppa il ciclo di letture pubbliche promosso dall’Istituto di studi italiani. L’iniziativa nasce dall’urgenza di restituire al conflitto il suo valore costitutivo e generativo, contro ogni tentativo di riduzione o cancellazione. Il conflitto non è visto come un’anomalia da eliminare, ma come uno spazio vivo di trasformazione, confronto e produzione di pensiero. |
Lunedì 20.10 | Aula A-11, Campus Ovest USI 18:00-19:30 |
Il conflitto cantato. Allegorie e metafore nel libretto d’opera seicentesco Giuliano Bellorini |