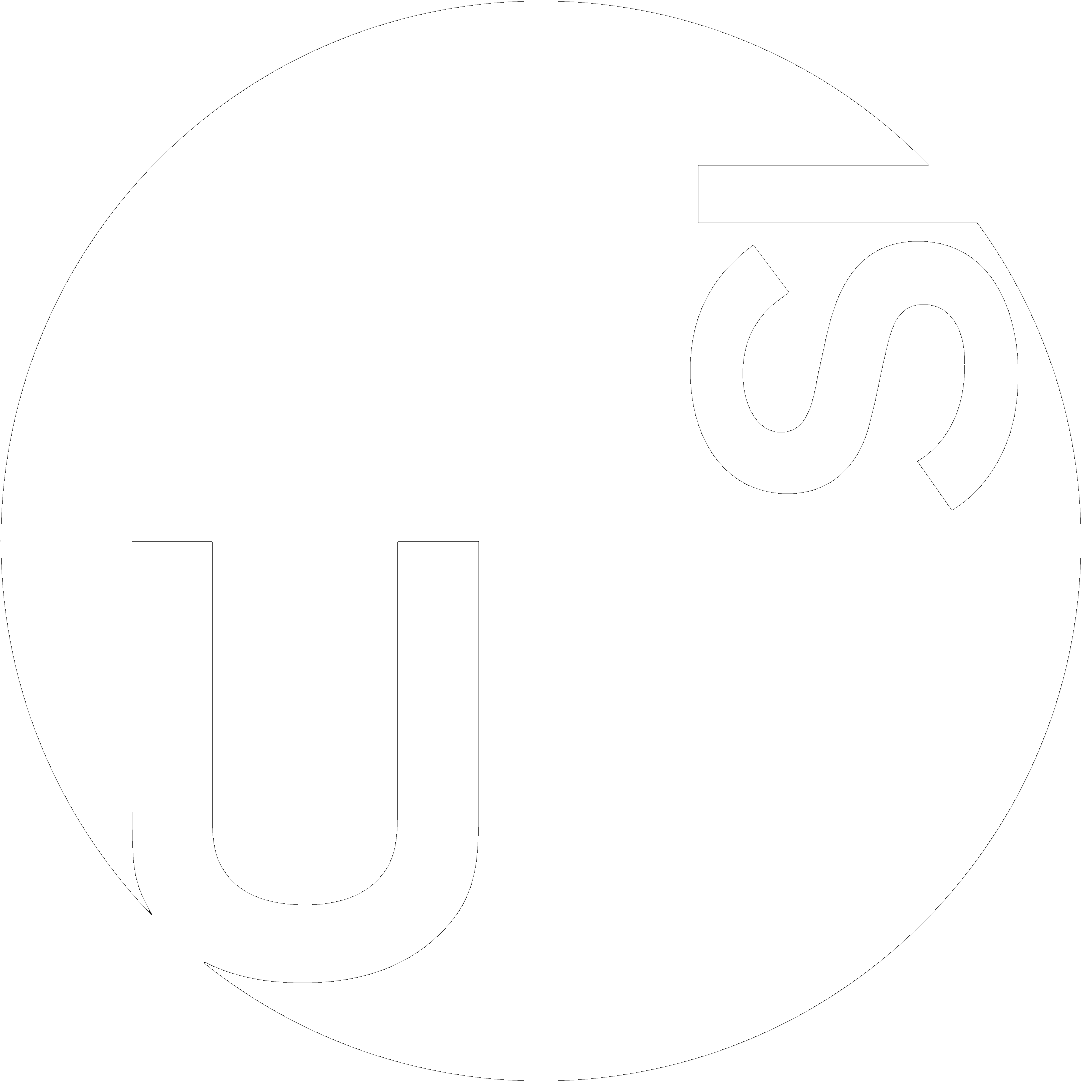|
| | Cosa può la letteratura, e come. Le forme del conflitto | | | |
| | «Come pensare il conflitto altrimenti che nella prospettiva del suo superamento?» A partire da questa domanda, formulata da Miguel Benasayag e Angélique Del Rey nel loro Elogio del conflitto, si sviluppa il ciclo di letture pubbliche promosso dall’Istituto di studi italiani. L’iniziativa nasce dall’urgenza di restituire al conflitto il suo valore costitutivo e generativo, contro ogni tentativo di riduzione o cancellazione. Il conflitto non è visto come un’anomalia da eliminare, ma come uno spazio vivo di trasformazione, confronto e produzione di pensiero. |
| | Lunedì 03.11 | Aula A-11, Campus Ovest USI 18:00-19:30 | | | |
| Il mio intervento affronta la scortesia in prospettiva storica: parole e formule con cui si offende l’altro, ieri come oggi. L’idea è semplice: anche quando crediamo di parlare d’istinto – per rabbia, disprezzo o frustrazione – ricorriamo spesso a espressioni prefabbricate, tramandate nel tempo.
Mi concentro su un caso tipico: le maledizioni del tipo «che ti venga…» (peste, colera, una fistola, ecc.). Esempi come «che ti venga il gavocciolo» (bubbone pestoso) compaiono in statuti e atti giudiziari medievali, mentre la teologia li considerava peccaminosi e blasfemi. Gli usi letterari (da Boccaccio a Goldoni, Verga, e oltre), analizzati tramite un grande corpus digitale, mostrano una preferenza per mali gravi (peste, rabbia), mentre gli usi benedicenti sono rarissimi. Nata nel Medioevo, la formula ha conosciuto periodi di scarsa diffusione e fasi di ritorno; oggi ricorre soprattutto come attacco verbale o sfogo, non come atto magico. In passato, invece, si credeva che la maledizione fosse “efficace”, cioè capace di far accadere ciò che si augurava. Per questo va distinta da insulti e minacce, dato che la si riteneva in grado di produrre effetti reali (ad es. stregoneria, scomuniche) grazie all’invocazione di un potere soprannaturale o spirituale.
Esistono dunque vere e proprie “grammatiche della scortesia”. La scortesia è, curiosamente, più stabile della cortesia: laddove molte formule cortesi cambiano o scompaiono, «che ti venga…» conta quasi sette secoli – e li porta benissimo. |
| |